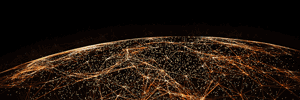Detroit . La capitale dell'auto, orti tra case in rovina.
Da paradiso dell'industria a inferno delle vittime delle ristrutturazioni, la metropoli arruginisce in una crisi infinita. E per sopravvivere si inventa l'«urban farming»: pomodori sotto i grattacieli. Da Il Manifesto del 19.11.2008
20 November, 2008
di Alessandro Coppola
Per anni il simbolo della crisi urbana americana, Detroit ne è ancora una delle realtà più dolorose. In un'epoca di - relativa - riurbanizzazione lungo entrambe le coste del paese e in un southwest in eterno boom, la città - come altre della cosiddetta rust belt, la «cintura della ruggine»: Philadelphia, Baltimora, Cleveland, Buffalo - rimane saldamente in perdita: di abitanti come di attività economiche. Decenni di automazione, delocalizzazioni e apertura dei mercati hanno fatto di Motor City, la capitale dell'industria automobilistica del paese, l'incarnazione di un incubo: quello della morte delle città e della dispersione dei loro abitanti.
La stretta e asettica downtown con i suoi grattacieli, negozi e ristoranti è oggi poco più di un'increspatura nel mare di abbandono e declino della città di cui dovrebbe essere il centro. Detroit ha perso in cinquant'anni metà della sua popolazione, dai 1.850.000 abitanti del 1950 si è passati ai 951.000 del Duemila. Una tendenza che non si è mai interrotta, neppure in tempi più recenti, quando gran parte delle città americane guadagnava nuova popolazione dopo i decenni più cupi della suburbanizzazione intensiva e della fuga di massa delle famiglie bianche dalle inner cities. In molti casi è stata l'impetuosa immigrazione degli ultimi anni a fare la differenza: senza latinos molte città non sarebbero mai state capaci di riacquisire quelle densità - di persone e attività - tali da renderle nuovamente attraenti anche per nuovi residenti di altro ceto e provenienza, la vera posta in gioco di molte delle politiche di sviluppo delle città americane.
Priva del mercato del lavoro che in molte concentrazioni urbane è quasi monopolio della nuova immigrazione - quello dei servizi poveri e poverissimi ad altissima densità di manodopera - Detroit non è attraente per la nuova immigrazione. La città rimane così dominata da una composizione razziale ormai anacronistica, in bianco e nero. Da un lato la minoranza bianca - il 10,5% nel 2000 a fronte del 83% del 1950 - e dall'altro la maggioranza afroamericana - circa il 16% cinquant'anni fa, l'81,5% nel 2000. Nel mezzo una ristretta pattuglia di immigrati soprattutto ispanici che, concentrati nella loro Mexican Town, non riesce ad alterare l'immagine e la realtà di una delle città più segregate d'America. Oltre i confini di una Detroit quasi del tutto nera, si estende infatti uno sterminato suburbio di circa 3 milioni e mezzo di abitanti, quasi tutti bianchi.
Dal food desert all'urban farming
Con il passare dei decenni la città si è quindi trasformata nel ricovero delle vittime delle ristrutturazioni produttive. Oggi Detroit è una delle città più povere d'America: un quarto dei residenti, un terzo dei bambini, vive con redditi inferiori alla soglia di povertà. Ma è anche la capitale degli irregolari: per il suo essere molto giovane, certo - quasi un terzo dei suoi abitanti ha meno di diciotto anni - ma soprattutto per la sotto-rappresentazione di quella che è la vera ossessione dell'ideologia nazionale della middle class: la famiglia mononucleare proprietaria dell'abitazione in cui vive. A Detroit, la maggioranza dei bambini vive in famiglie con un solo genitore e un'altra porzione abbondante ha genitori non sposati. In realtà qui ad essere protagoniste sono famiglie allargate nelle quali convivono fino a quattro generazioni diverse, una tattica per fare fronte ai redditi bassi e alla parossistica mancanza di servizi in una città che ha quasi del tutto perso la sua densità. A dominarne il paesaggio è infatti l'abbandono, in proporzioni che è difficile immaginare, tanto da spingere qualcuno a paragonare la città alla Berlino o alla Dresda post-bellica. Paragone che chi scrive aveva trovato irrispettoso prima di arrivare a Detroit.
Sono moltissimi gli edifici vuoti e sigillati, i terreni tornati verdi dopo le demolizioni, gli scheletri di case unifamiliari date alle fiamme dai loro proprietari che negli anni più acuti della crisi preferivano incassare i proventi dell'assicurazione anziché gli affitti magri e incerti dei loro inquilini. Il risultato è un territorio immenso in gran parte privo di abitanti e in via di rinaturalizzazione, composto da quartieri nei quali si possono trovare interi isolati abitati da non più di tre persone. Altra dimensione dell'apocalisse urbana, la pressoché totale desertificazione commerciale della città - la suburbanizzazione ha portato con sé non solo le persone ma anche le attività economiche, a partire dal commercio - che ha spinto un gruppo di ricercatori a definire la città come un food desert. Una ricerca pubblicata nel 2007 dalla Mari Gallagher Research and Consulting Group indica in 550.000 il numero di detroiters che vivono in quartieri nei quali l'assenza di una distribuzione alimentare di qualità rende difficile se non impossibile una dieta dignitosa. Il consumo dei beni reperibili sul mercati locali dei quartieri poveri - fatto di quelli che sono definiti fringe shops: soprattutto negozi di liquori nei quali è impossibile trovare prodotti freschi - peserebbe in modo significativo sulla minore aspettativa di vita dei loro abitanti. Il problema risederebbe soprattutto nella dipendenza di molti degli abitanti di queste aree della città dai food stamps erogati dal governo federale a residenti senza reddito o con redditi bassissimi. Solo una piccola minoranza degli esercizi commerciali che li ammettono vende prodotti diversi da alcolici, sigarette, biglietti della lotteria e una ristretta scelta di cibi in scatola. Sono così questi i componenti della spesa di molti detroiters, soprattutto di quelli - e sono tanti - che non hanno una macchina con la quale recarsi nei centri commerciali del suburbio, oppure che semplicemente non riescono più a sostenere i prezzi crescenti dei carburanti. «Inevitabilmente - mi dice Cevan Castle, una community organizer attiva nell'East Side della città - il ragionamento di molta gente è economico: 'vado a fare la spesa una volta sola al mese, il giorno in cui sono emessi i food stamp. Se ho la macchina risparmio sulla benzina, altrimenti risparmio sul taxi'. Così è impossibile acquistare verdura o frutta fresche, quello che si comprerà saranno scatole, scatole e scatole». Le soluzioni proposte e rimbalzate fra amministrazione comunale e organizzazioni di quartiere sono tante: dilazionare l'emissione dei food stamps, creare servizi di trasporto flessibili in una città in cui il servizio pubblico è quasi inesistente. Ma ad affacciarsi da qualche anno a questa parte è un'alternativa ancora più radicale, quella dell'urban farming.
«E'incredibile - dice Libby, un'altra organizer - solo cinque anni fa la stessa amministrazione comunale guardava all'urban farming come all'idea più ridicola mai presentatasi a Detroit. E ora con la recessione e tutto questo parlare di crisi ecologica e ritorno al locale, sono proprio loro i primi a dire che è un'idea geniale». Geniale quanto semplice, l'idea è di trasformare gli effetti devastanti dell'apocalisse urbana provocata dalla fine dell'epopea industriale della città, in un nuovo modello di sviluppo attraverso la conversione dei terreni abbandonati in fattorie urbane. Sul finire degli anni ottanta James Boggs, figura storica del community organizing a Detroit, immaginava una città molto diversa da quella annunciata dal suo sindaco di allora, il potente e controverso Coleman Young.
Casinò contro orti metropolitani
Alla pervasiva retorica della competitività urbana dell'amministrazione comunale, impegnata nella creazione di nuovi mercati a colpi di agevolazioni fiscali e trasferimenti pubblici a imprese e investitori immobiliari, Boggs opponeva la visione di una città capace di rigenerarsi attraverso la moltiplicazione di micro-imprese agricole e artigianali che utilizzassero i beni per lui più preziosi e abbondanti di Detroit: la grande disponibilità di acqua e terra, quella liberata dalle demolizioni, e le abilità di molti dei suoi abitanti, forgiate dall'eredità manifatturiera della città.
Agli occhi di Boggs l'apertura di un nuovo casinò, progetto di punta delle politiche economiche di Coleman, rappresentava una cura peggiore del male che si intendeva curare. Se i casinò nel frattempo sono diventati due, anche l'urban farming è in piena espansione in una città nella quale si stima la presenza di quarantamila lotti abbandonati. Il Garden Resource Program, nato su iniziativa di diverse organizzazioni no profit della città, gestisce 115 community gardens e 220 family gardens in tutte le aree della città, alcuni dei quali esplicitamente votati alla soluzione del problema dell'urban desert. Come nel caso del Capuchin Soup Kitchen, che su iniziativa di un ordine cappuccino nell'East Side produce e distribuisce frutta e verdura fresca ai negozi locali che accettano i food stamps, organizzando corsi di formazione riservati ai bambini del quartiere. Per accedere al Garden Resource Program è sufficiente versare una quota simbolica in cambio della quale si ricevono piante e sementi per avviare la propria piccola fattoria urbana. Con l'estendersi del fenomeno, l'amministrazione comunale si è trovata costretta ad ammetterne non solo l'esistenza e l'estensione ma anche il suo ruolo nella rivitalizzazione di molti quartieri. Gli stessi dispositivi di pianificazione della città formalizzeranno presto l'urban farming, riconoscendo per la prima volta l'inevitabilità della rinaturalizzazione di porzioni consistenti del suo territorio. La diffusione dell'urban farming ha fatto così di Detroit una delle capitali del movimento del buy local - le campagne per l'acquisto di prodotti organici locali per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l'alimentazione - che di norma è presente nelle ben più ricche città dell'est e dell'ovest, dove si concentrano i ceti narcisisti e i liberal benestanti.
Così morì Jefferson Avenue
Un destino, quello della rinaturalizzazione, che sembra destinato a compiersi anche nell'East Side. Jefferson Avenue era negli anni cinquanta una delle principali arterie commerciali della città. La chiusura e la delocalizzazione di molte delle attività manifatturiere presenti nell'area ne ha poi improvvisamente interrotto l'esistenza. Oggi della vecchia vibrante Jefferson Avenue, piena di negozi, ristoranti e cinema che servivano i tanti quartieri working class dell'area, rimangono solo insegne ammaccate dal sapore modernista. I marciapiedi sono deserti, i locali abbandonati e devastati tranne nel caso dell'immancabile negozio di liquori che sembra l'unica attività, fra le pochissime rimaste, a presidiare un mercato solido e riconoscibile. Qui l'impressione di uno spazio improvvisamente rarefattosi si approfondisce: sono moltissime le case abbandonate e i terreni di nuovo verdi. Decenni di disinvestimento hanno abbattuto i valori immobiliari, praticamente annullandoli in diverse aree del quartiere. «I miei genitori - dice Aron, un altro community organizer - hanno comprato una grande casa unifamiliare per 15.000 dollari e oggi stesso tu potresti comprarne una per non più di 20.000».
Ma nell'East Side lo spazio pur rarefattosi si coagula improvvisamente nelle tante nuove gated communities, i quartieri recintati cresciuti nel corso degli anni Novanta, e nel confinante comune suburbano di Grosse Point, uno dei più ricchi del paese. Nel giro di pochi metri il reddito pro capite può variare di centinaia di migliaia di dollari e una strada quasi abbandonata può condurre al check-point di un grappolo di ville con piscina o trasformarsi, superata la frontiera di Grosse Point, in un elegante viale commerciale che ricorda più la Costa Azzura che il Michigan deindustrializzato. Cevan lavora come Aron per Jeba, un'organizzazione di quartiere impegnata nella rivitalizzazione commerciale dell'East Side. Un compito particolarmente difficile nella città che ha inventato i grandi centri commerciali, negli anni Cinquanta, che ora si trovano quasi tutti nel suburbio, dove gli stessi abitanti delle gated communities presenti nell'East Side si recano a fare la spesa.
Per le famiglie povere, invece, la recente chiusura di un alimentari di quartiere ha avuto un impatto pesante sulla vita quotidiana. «Il pane da queste parti - ovviamente confezionato e non fresco - lo si può trovare nel liquor store o alla pompa di benzina», dice Cevan. Anche per questo Jeba ha deciso di promuovere con gli adolescenti del quartiere un progetto di urban farming grazie al finanziamento di un'università locale. L'idea è quella di una produzione locale di frutta e verdura che possa migliorare l'alimentazione degli abitanti del quartiere, impegnando giovani e adolescenti in un'attività imprenditoriale. Si tratta inoltre di combinare la nuova attività con quella di un laboratorio di riciclo confinante con l'area nella quale crescerà l'urban farming. Da anni a Detroit esistono gruppi che riciclano materiali di costruzione e pezzi di arredamento provenienti dalle case abbandonate o in via di demolizione: infissi, lampadari, scalinate, sanitari che vengono successivamente riutilizzati. «Tutti i materiali utili alla realizzazione dell'urban farm - dice Cevan - provengono dal laboratorio di riciclo. Preferiamo questa soluzione all'acquisto nei centri commerciali».
Anche nel deserto di Jefferson Avenue, Detroit, data per spacciata, tenta di trasformarsi. Da Motor city a Farm city.