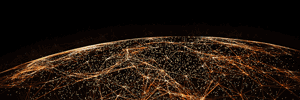Gregotti: archistar vil razza dannata
«Come i progettisti sovietici, ma al posto del realismo socialista adottano quello dei soldi». Parla l’urbanista che in un libro lancia l’allarme: la città sta per finire - da La Stampa.it del 17.04.2011
18 April, 2011
Francesco Rigatelli inviato a Milano
L’ultimo erede della linearità modernista, l’architettura dei Rogers, dei Belgiojoso, degli Albini che ha ridato semplicità all’Italia dopo il fascismo, lavora a un tavolo identico a quello dei suoi collaboratori nello studio a lui intitolato dietro il carcere di San Vittore. Davanti alla vetrata sul giardino interno gli fa compagnia una di quelle radio rosse che si aprono in due disegnate da Zanuso. «Musica classica, lavoro di squadra, ordine, precisione. L’ho imparato a Novara, nella fabbrica tessile di mio padre, insieme alle ragioni di tante lotte ma anche alla volontà di miglioramento». La Bossi, l’azienda di famiglia, ora è in mano ai nipoti e Vittorio Gregotti a 83 anni è il decano dei grandi urbanisti italiani.
Nel suo libro appena uscito da Einaudi, Architettura e postmetropoli, lancia l’allarme: la città sta per finire. Davvero possibile?
«Fuori dall’Europa la tendenza è questa. A grande velocità la metropoli rinuncia al disegno urbano per una periferia infinita. Il caos è l’ordine del nuovo mondo, anche se allo stesso tempo è un’attrazione per le campagne grazie al lavoro e al modello di vita promesso».
E per lei, allievo dei modernisti puri alla Rogers, di fronte alla postmetropoli non c’è stata una risposta adeguata dell’architettura postmoderna, per contribuire all’organizzazione della nuova città, tanto che la società ora rischia una postdemocrazia.
«Tutti dicono che sono finite la Storia, le ideologie e le classi sociali, ma non è così. Gli architetti danno risposte superficiali ed esibizioniste a questi problemi. Pensano a come verranno riprodotte le loro opere in tv invece che a come riorganizzare la città. E l’avanguardia non è più infrazione rispetto al passato, l’originalità è solo un obbligo mercantile. Il Museo d’arte contemporanea disegnato a Roma da Zaha Hadid per me è la massima espressione negativa di questo postmodernismo perché presenta grande confusione tra novità e nuovo».
I lavori di Renzo Piano, che è stato suo studente al Politecnico di Milano, le piacciono, invece?
«Lui ha uno stile diverso. Tenta di esprimere la tecnologia più avanzata del tempo in cui progetta. È il suo fine principale. Ma potrebbe pensare di più alla città come insieme anziché al gesto unico come simbolo in mezzo al caos».
A Torino si è discusso su due grattacieli progettati uno da Piano e l’altro da Fuksas. Che ne pensa?
«Il primo è inutile e comunque poteva progettarlo con qualche piano di meno. Così alto è solo speculazione e Intesa San Paolo ha sbagliato a domandare una soluzione simile. Il secondo è assolutamente inutile».
Di Massimiliano Fuksas criticò anche la Fiera di Rho.
«La Fiera, come l’Expo, è un simbolo di decadenza. Perché la gente compra sempre più su Internet che al mercato. E anche lì non c’è nessun pensiero contestuale. Insomma, la creatività non può esprimersi soggettivamente con gesti autonomi, ma in rapporto con la storia del luogo».
L’olandese Rem Koolhaas, in questi giorni ospite a Torino di «Biennale democrazia», è l’architetto del momento. Lo conosce?
«Anni fa l’ho pure aiutato a vincere un concorso. Una volta sosteneva una città senza storia e ideologie in cui ognuno fa ciò che vuole. Ora si è pentito e si è convertito in eco: una moda mercantile, perché se non sei verde oggi non vendi. Ma il suo è solo l’opportunismo tipico di chi rappresenta lo stato delle cose, non l’alternativa. Io accuso le archistar di essere come gli architetti sovietici, solo che al posto del realismo socialista adottano quello dei soldi».
Il progetto cui è più legato?
«La Bicocca, il rifacimento di una periferia perché non fosse più monofunzionale e monosociale ma varia di università, teatro e aziende».
Il tutto appare un po’ squadrato.
«Non me ne frega niente. Il mio modello è Venezia, dove tutto è spazio pubblico. La storia della Bicocca è industriale e il risultato non poteva che essere lineare e ordinato».
Razionalista come lei. E il quartiere Zen di Palermo lo rifarebbe?
«Col senno di poi rifiuterei di progettarlo o lo penserei diversamente. Però la verità è che lo rifarei uguale se avessi la garanzia che venisse realizzato come lo progettai. Ma si mise di mezzo la mafia per boicottarlo».
A oltre 70 anni lei ha iniziato a progettare città satelliti vicino a Shanghai. Come mai?
«La figlia di Deng Xiaoping m’invitò a partecipare a un concorso dopo un convegno. La Cina è l’unica civiltà rimasta in piedi dal 2000 a. C., non una nazione ma una civiltà».
Come direttore della rivista Casabella, ha formato generazioni di architetti per 14 anni. E poi?
«Berlusconi ha comprato Mondadori e il suo dirigente Maurizio Costa mi ha licenziato perché sono di sinistra. Da allora ho iniziato a scrivere libri».
Tra cui nel 1986 Il disegno del prodotto industriale, primo testo sulla Storia del design, che però lei non chiama mai così. Perché?
«Forma e funzione hanno un ordine. Il design si è riversato sull’architettura come se fosse un oggetto. Basta girare per Milano in questi giorni e si capisce che non si possono inventare venti sedie all’anno se non per un superfluo scopo mercantile senza dignità d’arte».