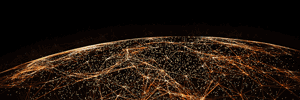Porta Palazzo L'eco sistema della solidarietà
Da "I giovani guardano Torino" - La Stampa del 23 luglio 2017
24 July, 2017
Il «College Reporting» è il corso della Scuola Holden (www.scuolaholden.it) in cui si studia la mescolanza tra informazione, giornalismo e narrazione del reale. All’inizio del 2017, gli studenti hanno ricevuto dal loro maestro Ezio Mauro l’incarico di realizzare un’inchiesta sulla povertà a Torino. Ogni reporter ha scelto un quartiere, una persona, una storia: dal centro alla periferia, da San Salvario alla Falchera, dai portici di via Roma ai banchi del mercato di Porta Palazzo. Il risultato è una mappa in sedici reportage, in cui si intrecciano vicende personali e drammi collettivi, solidarietà sociale e dignità umana. Sono quelle fotografie della città che non finiscono mai sulle cartoline, ma che sono sempre sotto i nostri occhi, ancor di più oggi che la crisi economica ha ampliato il perimetro della povertà, fino a sfiorare la base della classe media. A catturarle è lo sguardo di sedici allievi, tutti sotto i trent’anni, provenienti da diverse regioni d’Italia. Oggi, quarta puntata, si conclude la pubblicazione delle storie parte di questo progetto selezionate dal direttore Maurizio Molinari e dalla redazione di Torino.
Luca Castelli, coordinatore del College Reporting
Porta Palazzo non è un semplice mercato. È un’identità, è un simbolo, è un marchio di fabbrica. È un ecosistema composito di ingranaggi umani che ogni giorno con le loro storie, silenziose ai margini vicino ad un cassonetto o urlate dietro i banchi della frutta, danno vita ad una delle realtà più interessanti della città di Torino.
A spiegarmi meglio la situazione complessiva del mercato è Splendore Durante, psicologa di comunità del progetto The Gate, un’Agenzia di Sviluppo Urbano che ha come scopo la valorizzazione e riqualificazione del quartiere di Porta Palazzo: «Questa zona è il luogo dell’accoglienza, è il ventre molle di questa città, per cui se vuoi sapere che cosa accade in città devi venire a Porta Palazzo perché qui accade prima, nel bene o nel male. Una volta si diceva che Porta Palazzo era l’internet dei poveri, perché è un luogo di arrivo in cui le persone trovano qualcosa, appunto il cibo o le altre persone; qui c’è la povertà perché c’è anche una risposta alla povertà. È un quartiere molto complesso e nella complessità si apre uno spazio enorme».
Ed è proprio in questo “spazio enorme” che sono andato a ricercare alcune delle realtà che fanno di Porta Palazzo un marchio di fabbrica riconoscibile da chiunque.
Le Sentinelle dei rifiuti
Sono le 13 di un giorno particolarmente assolato quando mi dirigo verso il camion compattatore posizionato davanti alla fermata Porta Palazzo Sud. È di un verde acceso ed è sempre nello stesso punto, impossibile non riconoscerlo. Ad aspettarmi trovo una ragazza minuta e sorridente, capelli corvini, indossa una pettorina arancione fluorescente ed è circondata da altrettante persone vestite uguale. Il suo nome è Erika, viene dall’Argentina ed è una delle mediatrici culturali che si occupa di coordinare sul campo il progetto Sentinelle dei Rifiuti. Ogni giorno, prima di iniziare la raccolta della frutta e della verdura riciclabili, Erika fa il giro di tutto il mercato ortofrutticolo salutando ad uno ad uno tutti gli ambulanti. Ha un’energia esplosiva e fatico a tenere il suo passo. Mentre la seguo mi spiega in che cosa consiste il progetto. «Tutti i ragazzi che vedi sono rifugiati richiedenti asilo e fanno parte del programma di accoglienza, per loro venire qui non è vissuto come un obbligo ma anzi, è un modo per stare assieme e divertirsi, molte volte portano anche degli amici che ci danno una mano. Gli ambulanti ci danno i prodotti che domani non sarebbero più buoni per essere messi in vendita, noi li raccogliamo e poi allestiamo un banchetto a fine mercato in cui le persone possono prenderli gratuitamente». Parla veloce e si interrompe spesso per dispensare un saluto, una battuta o una gentilezza con ogni ambulante. Il tutto nella loro lingua madre. “Lebes” e “koulchi mezien” sono le parole che ripete più spesso. «Lebes è il saluto marocchino, potresti dire anche salam alekum ma è un po’ più religioso ed alcuni possono offendersi visto che io non sono musulmana, invece koulchi mezien significa come stai sempre in marocchino, sai per loro è bello se tu li saluti nella loro lingua e a me fa piacere». Erika parla perfettamente italiano ed oltre al marocchino mastica anche la lingua mandinga, quella bambara e recentemente ha imparato inglese e francese che usa con scioltezza. Le chiedo qualcosa in più sulla sua storia personale, è molto disponibile e quando inizia a parlare sembra un fiume in piena: «Vengo da un paese povero vicino a Rosario, ma povero nel senso che non avevamo i soldi per comprare le scarpe. Già a dodici anni avevo il sogno di andare in un altro paese e dopo dieci anni, quando ne avevo ventidue, sono partita da sola per l’Italia. Io ho il mio bisnonno che era italiano così quando sono arrivata ho iniziato subito le pratiche per ottenere la cittadinanza. Ho fatto otto anni qui a Torino arrangiandomi come potevo, nel frattempo mi aveva raggiunto anche il mio attuale ex-marito e qui ho avuto il mio primo figlio». Ora ne ha tre, gli altri due li ha avuti negli otto anni successivi trascorsi a Barcellona, città nella quale decide di trasferirsi in seguito alle difficoltà incontrate qua in Italia. Ma nel 2015 dopo anni di convivenza difficile con il marito dal quale si stava separando, sceglie di tornare a Torino con i suoi figli. «E lì mi sono chiesta, ora come mi riciclo? Ho visto un corso di mediatore culturale e mi piaceva l’idea, così mi sono iscritta ed una volta uscita da lì ho fatto il tirocinio nel campo profughi della Croce Rossa di Settimo Torinese e ora…eccomi qui!». Mi spiega che con quello che fa adesso, mantenere una famiglia con tre figli non è facile e grazie agli alimenti dell’ex-marito riesce ad arrivare precisa a fine mese. Ma mentre me lo dice nella sua voce non c’è un minimo di compianto e men che meno di tristezza.
Parla con serenità, ride e scherza volentieri, la sua gioia di vivere infonde allegria e buon umore a chiunque la incroci. L’atmosfera che si respira anche sul posto di lavoro quand’è con i ragazzi richiedenti asilo è sempre di convivialità e di festa.
Modou
Già dopo qualche giorno ho preso confidenza con diversi ragazzi che partecipano al progetto. Ci si diverte come sempre, ci scambiamo battute in italiano, inglese, francese e un po’ anche in mandinga. Non vengo trattato come un estraneo e anzi la cordialità e la disponibilità sono all’ordine del giorno. Chiedo ad uno di loro se ha voglia di raccontarmi di sé. Si chiama Modou e viene dal Gambia. Ha 26 anni ed è arrivato in Italia nel 2015. Quando gli chiedo come è arrivato sin qui lui mi risponde «in autobus», intendendo qua a Torino. Così cerco di spiegarmi meglio e gli dico che mi riferisco al viaggio dal Gambia all’Italia. Mi risponde lentamente «in barca», ma poi qualcosa si blocca, vedo i suoi occhi offuscarsi e le sue labbra stringersi. Sembra non essere più presente, è come se il suo cervello gli avesse inviato un messaggio di errore. Mi affretto a dirgli che non importa, di stare tranquillo che possiamo andare avanti. Così gli chiedo come si sente adesso e la risposta è immediata: «Mi sento bene, libero. Amo venire qui al mercato per aiutare la gente, non ho soldi da dargli e almeno posso fare qualcosa per loro. Anche in Gambia facevo volontariato, mi piace essere utile per qualcun altro».
Ad un certo punto gli domando se ha un sogno. Lui sorride e mi risponde che ora come ora non ne ha uno preciso. Capisco che c’è qualcosa che vorrebbe dirmi e lo incalzo chiedendogli se neanche da bambino ce l’aveva. A quel punto il sorriso diventa più largo e ci intravedo un leggere imbarazzo. «Volevo fare il pilota di aeroplani o elicotteri. E poi anche il Ministro del Turismo». Sorpreso da quest’ultima risposta gli chiedo di raccontarmi di più: «Io prima di venire qua studiavo arte e facevo parte di alcune associazioni che, si insomma, si occupavano di questo». Poi prosegue dicendomi che ora sta frequentando un corso per diventare meccanico e che gli piacerebbe molto lavorare in questo settore. Quando la conversazione sta per concludersi ci tiene a precisare un’ultima cosa: «Il dialetto della mia regione si chiama Tesito, che però è anche un proverbio. Letteralmente sarebbe “stringi la cintura”, significa stringi la cintura perché devi essere forte e pronto per camminare».
Michele
Alle 14 in punto le Sentinelle danno il via e attorno alle cassette di frutta e verdura si forma immediatamente un capannello di gente che racimola più velocemente che può tutto quello che riesce. Il lavoro dei ragazzi consiste anche nell’evitare scontri fra i frequentatori e spesso dividere arbitrariamente il cibo, vigilando su chi vorrebbe accaparrarsi più del dovuto. C’è anche qualcuno però, che rimane in disparte ed aspetta che i più voraci si siano tirati indietro per poter fare le cose con calma. Fra di loro c’è anche Michele, pensionato torinese, ex dipendente comunale. Vedo che dopo essersi servito al banco, fruga un po’ anche nella spazzatura. Mi avvicino con una scusa, è cordiale e risponde subito alle mie domande: «Vengo qui per trovare qualcosa di buono, ma non solo per me anche per una signora che è disabile nella casa in cui abito io, allora se trovo un po’ di costine un po’ di broccoletti mia moglie ce li cucina e glieli portiamo». Ha un carrettino di tela nel quale raccoglie la sua “spesa” e si aiuta a camminare con un bastone consumato. Ha una corporatura striminzita che copre con vestiti larghi e consumati. Mi dice di avere 89 anni e a prima vista sembra davvero averne di meno. Mi complimento e scherzando dico che non ci credo.
Laura e Maria
Ci sono anche dei ragazzi e delle ragazze che a fine mercato effettuano la raccolta in autonomia. Fra di loro ci sono Laura e Maria, tutte e due collegate alla Cavallerizza, uno spazio autogestito nel cuore di Torino. La prima è una studentessa belga in Ecologia Sociale e si trova a Torino per uno stage nell’associazione “SalviAMO la Cavallerizza”, la seconda invece è torinese e partecipa attivamente alle iniziative della Cavallerizza. Chiedo a Maria per quale motivo facciano il recupero. «Inizialmente ci serviva per la cucina dell’abitativo (diverse persone abitano all’interno del centro autogestito, ndr) poi però circa un anno e mezzo fa abbiamo inaugurato La Zappata che è la cucina popolare autogestita in cui prepariamo pranzo e cena per chiunque voglia ed il contributo è up to you».
Annetta
«Giovanni! Giovanni vieni qua! La mangi la focaccia? Tieni!». Entrare in confidenza con Anna non è stato difficile, dopo due chiacchiere con il genero, mi stava già regalando una dozzina di mele ed ora mi chiama a gran voce per offrirmi un po’ di focaccia pugliese. Le chiedo com’è la vita dell’ambulante: «Allora, prima avevo mio marito, lui è mancato quattro anni fa in un incidente, quindi io ho cambiato vita: ora sono io che mi sveglio tutti i giorni alle 3 di mattina con mia figlia e andiamo al mercato generale e a comprare e poi massimo otto e mezza abbiamo tutto pronto». Riferendosi al genero, Massimo, un ragazzo arzillo tatuato fino al collo, «adesso lui scarica e carica, porta in magazzino ed io arrivo a casa alle sedici. Questa è la nostra vita». Anna è pugliese, è arrivata a Torino quando aveva tre anni. Mi racconta che prima di fare l’ambulante era una parrucchiera, poi la madre ha chiuso bottega e i suoi genitori hanno comprato il primo banco. Si sfoga dicendo che è una lotta ogni giorno: la concorrenza, le spese da pagare e la convivenza con gli altri ambulanti. «Ma dobbiamo andare avanti». La conversazione prende subito una piega più spiritosa e confessandomi il suo debole per la carne di cavallo passiamo ad argomenti più leggeri. «Ma te il giornalista devi fare? Ma si dai vedrai che farai carriera e poi dopo mi penserai, ti vedremo alla televisione e poi sul giornale parli di Annetta».
Sharki
«Le vedi quelle? Una là, poi questa e sei vai di là vedi le altre. Queste sono state messe dopo, quelle segnano il perimetro di Porta Palazzo. Se tu entri, se tu stai dentro, ma veramente dentro allora puoi capire qualcosa». A parlarmi è Sharki, un operaio marocchino addetto al montaggio e smontaggio dei banchi del mercato. Quando lo incontro per la prima volta gli chiedo ingenuamente se posso fargli qualche foto mentre lavora. È diffidente e sospettoso ma accetta ad una condizione: «Poi me le porti però, sono di parola io». Glielo prometto e lo rassicuro sul fatto che anche io sono di parola. Quando torno dopo qualche giorno mi viene incontro a grandi falcate con un enorme sorriso stampato sulla bocca: «Sei tornato!» Baci e abbracci di ogni genere, mi ringrazia mettendosi una mano sul cuore «È importante sai, qua non c’è niente che possiamo dare, solo la parola e tu l’hai mantenuta sei stato rispettoso». Mentre guarda le foto mi dice: «sono importanti per me perché poi quando mio figlio diventa grande vede che cosa fa suo papà tutti i giorni». Ha un figlio di quattro anni che ha lasciato in Marocco assieme alla moglie ed ogni tanto riesce a tornare a trovarli per qualche mese. Mi racconta che sono ormai diciassette anni che è lì e prima di lui suo padre e i suoi fratelli sono passati su quella piazza. È un uomo ligio al dovere e non si lamenta di quello che fa, anzi ne è grato e ne va fiero. È felice di essere lì a lavorare e sottolinea sempre come tutti i suoi colleghi siano molto di più, una vera e propria famiglia. Un giorno mi porto dietro la macchina fotografica per fare qualche scatto e non faccio in tempo a sollevare la mia reflex che sento da dietro una voce che mi chiama: «Ehi! Sei fotografo? Fai foto anche a noi, fai foto!» Un altro uomo molto divertito dalla situazione parla arabo con altre persone e raduna diversi operai della piazza. Giocano e ridono, si mettono in posa assieme a Sharki il quale successivamente mi chiede se so che cosa ha detto l’uomo di prima. «Ha detto, facciamo queste foto perché domani qualcuno di noi potrebbe non esserci più».